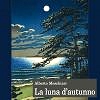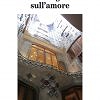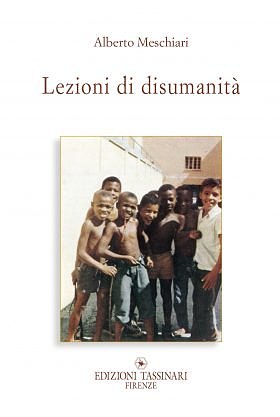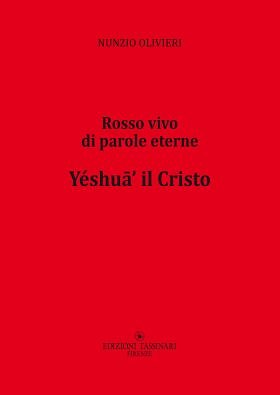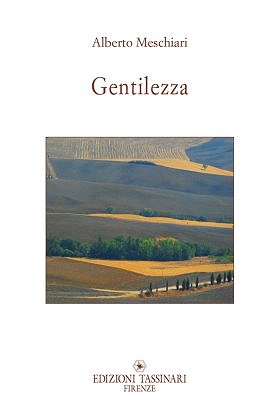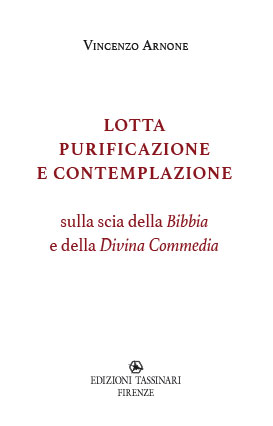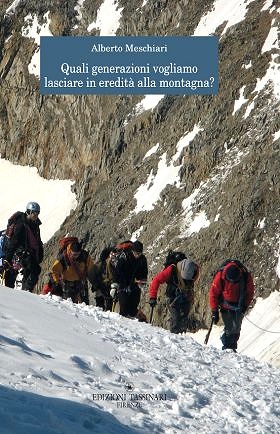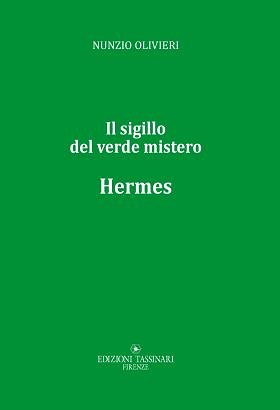-
×
 Da Sarajevo a Hiroschima (Quaderno 17)
1 × €24,00
Da Sarajevo a Hiroschima (Quaderno 17)
1 × €24,00 -
×
 I Persiani
1 × €18,00
I Persiani
1 × €18,00 -
×
 La Croce Rossa Italiana nell’alluvione del 4 novembre 1966, Il ruolo del Comitato di Firenze (Quaderno 18)
1 × €15,00
La Croce Rossa Italiana nell’alluvione del 4 novembre 1966, Il ruolo del Comitato di Firenze (Quaderno 18)
1 × €15,00 -
×
 Medea
1 × €18,00
Medea
1 × €18,00 -
×
 Bricconcelle di porcellana
1 × €15,00
Bricconcelle di porcellana
1 × €15,00 -
×
 La C.R.I. dal Risorgimento alla vigilia della Grande Guerra (Quaderno 16)
1 × €15,00
La C.R.I. dal Risorgimento alla vigilia della Grande Guerra (Quaderno 16)
1 × €15,00 -
×
 AD ARIEL. CON UN RAMO DI GINEPRO
1 × €15,00
AD ARIEL. CON UN RAMO DI GINEPRO
1 × €15,00
Subtotale: €120,00

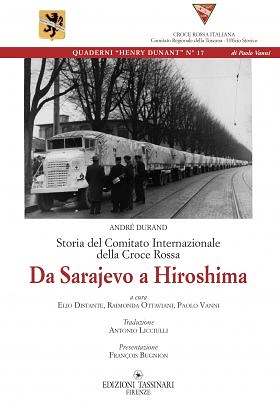 Da Sarajevo a Hiroschima (Quaderno 17)
Da Sarajevo a Hiroschima (Quaderno 17) 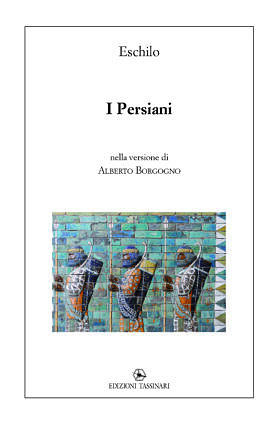 I Persiani
I Persiani 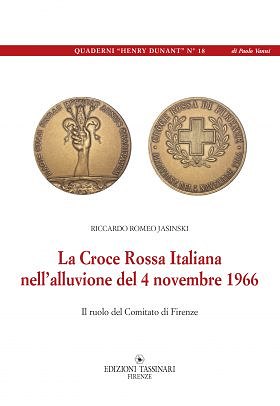 La Croce Rossa Italiana nell’alluvione del 4 novembre 1966, Il ruolo del Comitato di Firenze (Quaderno 18)
La Croce Rossa Italiana nell’alluvione del 4 novembre 1966, Il ruolo del Comitato di Firenze (Quaderno 18) 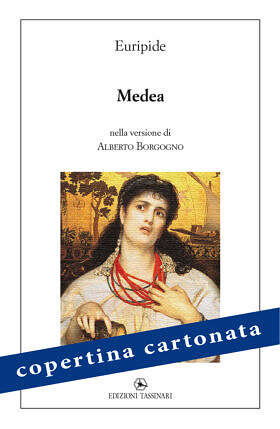 Medea
Medea 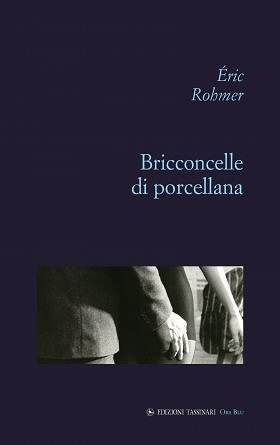 Bricconcelle di porcellana
Bricconcelle di porcellana 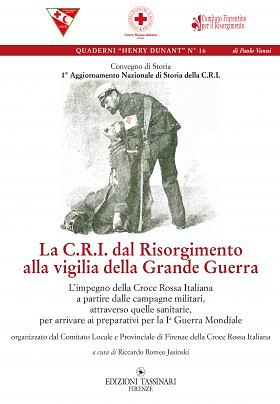 La C.R.I. dal Risorgimento alla vigilia della Grande Guerra (Quaderno 16)
La C.R.I. dal Risorgimento alla vigilia della Grande Guerra (Quaderno 16) 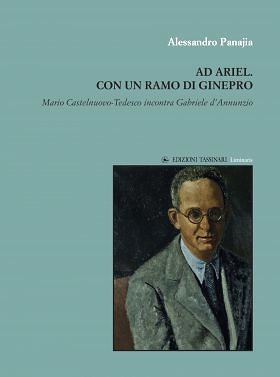 AD ARIEL. CON UN RAMO DI GINEPRO
AD ARIEL. CON UN RAMO DI GINEPRO